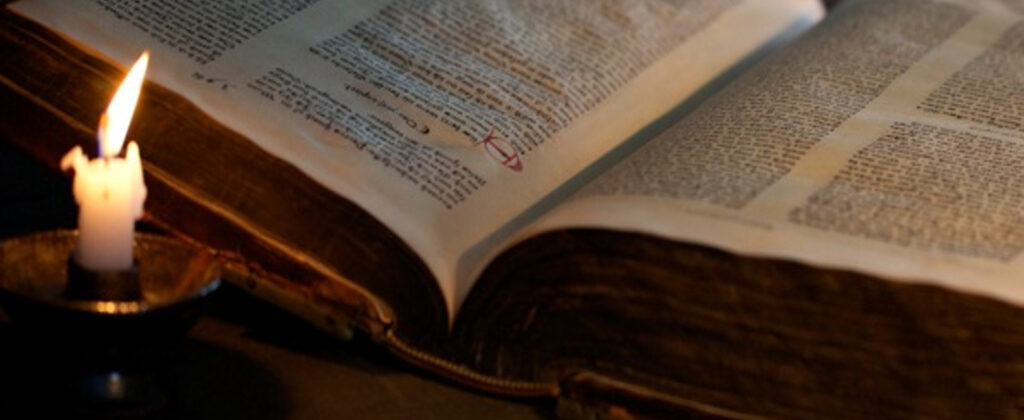
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,15 – 20).
Tutti sappiamo per esperienza che un rimprovero non serve a nulla, se l’altro non sente o non vuol sentire. Ma se si tratta di qualcosa di molto importante, ci lamentiamo con qualcun’altro, forse anche con il superiore. I bambini vanno a lamentarsi con i genitori o con gli insegnanti, gli adulti si rivolgono alla polizia o ai tribunali, ma chi accusa generalmente non ha buona fama. Il Vangelo dice che si ricorre all’autorità come ultima soluzione, e solo dopo il fallimento di tutte le precedenti iniziative: bisogna preferire la composizione dell’incidente a quattrocchi, e poi in presenza di testimoni. Solo alla fine si può arrivare all’accusa pubblica. Non si tratta di una procedura giuridica, ma l’espressione di ciò che si chiama “spirito dialogale e collegiale” della Chiesa. Si suppone che i cristiani siano capaci di superare le differenze di opinione con il dialogo e la buona volontà e che ambedue le parti siano disposte a cedere il più possibile all’altro. La pertinacia assoluta in una presa di posizione erronea di per sé esclude dalla Chiesa, dalla convivenza nell’amore.
La parola carità nel mondo laico è intesa soprattutto come opera materiale, ma nel mondo monastico era intesa come aiutarsi a scoprire reciprocamente e correggere i propri difetti.
Se fossimo sempre fedeli al monito evangelico di ammonire il peccatore, si innescherebbe un movimento davvero veritativo, spirituale, sociale e politico. Quando c’è una questione che riguarda la carità, non servono regole scritte, come accade in famiglia o fra amici: si fa notare spontaneamente che qualcosa non va. L’importante è non usare un tono aspro, come chi ammonisce solo per il fastidio che dà il comportamento del prossimo, senza amarlo minimamente. Agendo in questo modo, si finisce con il ferire, offendere e provocare un litigio. Qualsiasi rimprovero va fatto con amore e, se lo si “sa fare” serenamente, verrà accolto volentieri. Quando l’altro sente che tu lo ami, allora la correzione diventa anzitutto un atto d’affetto. In altre parole, la correzione fraterna viene dal capire bene il verbo latino cum – regere, che significa “reggere insieme”.
Aver spiegato al prossimo il suo errore non implica il suo cambiamento e non gli toglie la sua debolezza, ma esige il mio impegno. La correzione fraterna è sempre un atto d’amore. Se soffri per lui vedrai che, come dice con saggezza la Chiesa, saprai dire la verità nel tempo e nel luogo opportuni e riuscirai anche ad attendere, prima di parlare, il momento in cui Dio ti darà la chiave di quel cuore.
