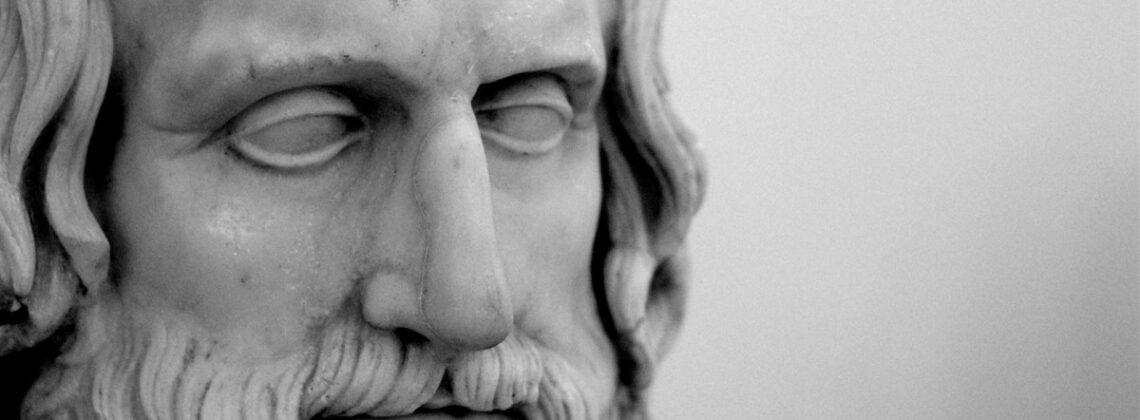
“Quando avremo fatto vedere l’oscurità dell’aldilà presso gli antichi, il loro disperato sentire che la morte è la fine di tutto, si potrà intravvedere da quale abisso di tenebre e di dolore l’anima antica abbia levato il suo grido a Dio”
di Lucia Menichelli
Una famosa vicenda mitologica trattata dai tragici ateniesi è quella della passione amorosa che travolge Fedra per il suo figliastro Ippolito. Si ha notizia che già Sofocle (496 a.C. – 406 a.C) abbia inscenato un dramma dedicato alla sfortunata eroina, di cui però è rimasto un testo del tutto frammentato. E’ invece sempre una tragedia di Euripide (480 a.C. – 406 a.C) che consacrò una fama duratura al personaggio, in una tragedia che in vero non porta il titolo corrispondente al nome della donna, ma a quello di colui sul quale convergono gli snodi della trama: Ippolito.
Ippolito è figlio di Teseo, che ha sposato in seconde nozze Fedra. Il ragazzo è un giovane casto, profondamente devoto ad Artemide e all’attività che questa dea protegge, la caccia praticata in luoghi lontani dalla presenza umana. La sua vita rifugge dalle seduzioni del piacere, egli non mostra di perseguire altro interesse se non la coltivazione di un’aristocratica virtù.
Questa convinta propensione scatena l’ira della dea dell’amore Afrodite che, stizzita dallo sprezzo di Ippolito nei confronti dei suoi “doni”, decide di punirlo scatenando nella sua matrigna una passione insana che le sconvolge la mente, al punto che dopo un lungo travaglio interiore la donna decide di suicidarsi, divorata dai sensi di colpa ma anche disonorata dal rifiuto dell’avance fatta al figliastro. Ma, prima di morire, Fedra si vendica. Lascia scritto il motivo del suo gesto, offrendo una versione ribaltata dei fatti: Ippolito l’ha insidiata e lei, per la vergogna, non può più vivere. Il marito Teseo, già disperato, quando viene a conoscenza dell’estrema testimonianza della donna, si infuria col figlio e lo caccia via, maledicendolo e invocando su di lui la vendetta del dio del mare Poseidone. Così, mentre Ippolito fugge un mostro marino si manifesta davanti al suo carro, il ragazzo ne perde il controllo e viene trascinato dai cavalli.
Nel frattempo però il padre ha saputo la verità dalla stessa dea Artemide: accorre a salvare il figlio, ma troppo tardi. Fa in tempo però a stringerlo tra le braccia e a parlargli per l’ultima volta. Questa scena conclude definitivamente la vicenda, in cui in effetti si sono concentrati i due drammi paralleli di Fedra e di Ippolito.
Il finale del dramma rivela due particolari che costituiscono delle vere e proprie novità nel teatro tragico greco. Ippolito muore con il corpo piagato, per le ferite riportate dall’incidente che ha subito: un fatto veramente insolito per il teatro greco, sempre attento a non mostrare scene di sangue e a non rappresentare morti o uccisioni davanti agli occhi del pubblico. Quest’eccezione potrebbe essere altamente significativa: Ippolito è un giovane giusto che non solo non ha commesso il male, non solo compie azioni positivamente buone, ma vive quasi in uno stato mistico, e nonostante ciò il destino tragico lo coglie ugualmente attraverso la cieca vendetta di Afrodite. Il suo corpo piagato, allora, sembra profilare un nuovo paradigma, che non assegna più agli eroi quell’ideale omerico della kalokagathia in virtù del quale la bellezza del corpo deve restare intatta anche in punto di morte (la “bella morte”) e perfino dopo (il rito del funerale eroico prevedeva infatti la cremazione del cadavere che doveva essere preservato dalla decomposizione, quindi dalla bruttezza). Ippolito è un “giusto” sofferente che muore innocente, è un martire, cioè un testimone dell’insufficienza della religione olimpica che non premia i giusti, ma soprattutto non dà significato alla sofferenza. E la deturpazione del suo corpo lo dimostra.
La seconda novità del finale scaturisce dalla prima: poco prima che Ippolito muoia, scende dal cielo Artemide a dargli parole di conforto, ma quando lui entra in agonia la dea si allontana (“E ora addio! Non mi è permesso vedere i defunti, contaminarmi col fiato di chi muore”, vv.1437-1838), ripristinando quella distanza incolmabile tra celesti e mortali. Ma ecco che Ippolito, rimasto solo col padre, invece delle consuete parole di vendetta pronunciate dai moribondi (vendetta, che peraltro Artemide ha promesso al ragazzo di perpetrare contro Afrodite uccidendo l’uomo da lei più amato), nell’ultimo commovente colloquio col padre, rivolge a lui parole di perdono (“…padre, ti assolvo da ogni colpa”, v.1449). La sua devozione non è bastata a interrompere il ciclo ininterrotto di punizioni e vendette operate dagli dèi, ma gli ha permesso di finire la sua vita rivolgendo un gesto di amore filiale e compiendo un gesto che prefigura il perdono cristiano, presagio della consolazione della misericordia, sebbene essa sia ancora tutta umana.
Sono particolarmente suggestive a tal proposito le parole del teologo belga Charles Moeller (1912-1986): “Quando avremo fatto vedere l’oscurità dell’aldilà presso gli antichi, il loro disperato sentire che la morte è la fine di tutto, si potrà intravvedere da quale abisso di tenebre e di dolore l’anima antica abbia levato il suo grido a Dio. E il suo grido divenga il nostro. Rifacciamoci un’anima precristiana”.
Sabato, 29 novembre 2025
