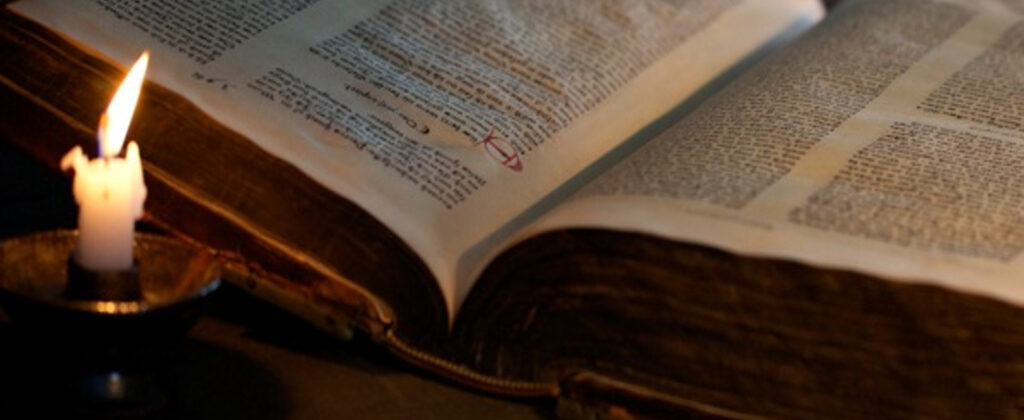
In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori della Legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito!» (Lc 11,42 – 46)
Secondo la legge d’Israele, si era obbligati a pagare la decima, allo scopo di mantenere il Tempio con i suoi sacerdoti (Gn 28,22). Veniva pagata sulle primizie dei raccolti della terra, perché i primi raccolti sono generalmente migliori. Gli Ebrei, come i Babilonesi e gli Egiziani, offrivano il primo raccolto alla divinità. Secondo la legge del Levitico si pagavano le decime sul primo olio nella settimana pasquale (Lv 23,10ss) e il primo grano a Pentecoste (Lv 23,17). Successivamente compare la decima sul proprio guadagno, per il mantenimento del sacerdote. I farisei erano molto scrupolosi nel pagamento di questi tributi, ma vennero sonoramente sgridati da Gesù perché il denaro, per loro, era ormai un fine a sé stesso, mentre invece deve essere un simbolo dell’amore e della sincera devozione a Dio. Generalmente la gente in chiesa si mette a sedere negli angoli più nascosti. E’ un atteggiamento discutibile, perché un cristiano non si vergogna della sua fede. Gesù, però, ci invita a pregar di nascosto (Mt 6,18).
Sono due aspetti indispensabili. La preghiera liturgica è professione comune della fede del popolo e segno dell’unità della chiesa, ma la preghiera è colloquio con Dio, assai più intimo quando è privato. Il Concilio Vaticano II spiega questo ragionevole compromesso. La liturgia è preghiera accomunante e esprime l’unità dei valori di un sodalizio cattolico, ma questo aspetto sociale deve essere completato dalla sincera devozione, nel rapporto personale con Gesù. Ciò è indispensabile affinché le nostre preghiere non scadano in atteggiamenti farisaici. E’ molto rasserenante per un sacerdote essere salutato lungo le strade, in virtù dell’abito che indossa. Ma questo capita anche a dei santi laici, impegnati nella chiesa. E’ un saluto che supera la semplice presenza personale: in realtà è Gesù stesso che viene riconosciuto e salutato. E’ possibile accettare santamente lodi e saluti, mostrando vera umiltà, perché questa venerazione appartiene solo a Dio, autore del grande dono della fede. E’ come osservare una santa immagine, che vale per ciò che raffigura, non tanto per sé medesima. Così noi stessi, quando non ci attribuiamo i meriti di Dio ma le nostre buone opere sono notorie, siamo per chi ci incontra il profumo di Cristo, così che tutti possano ricordarsi di Dio.
