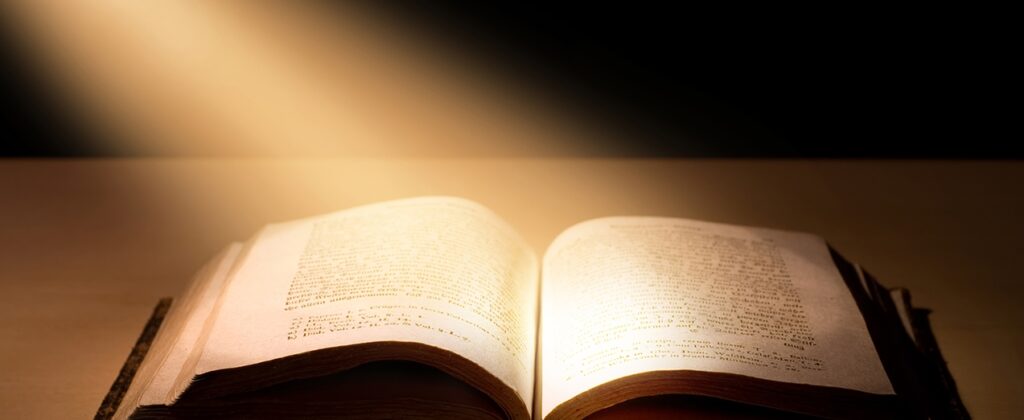
IV Domenica di Pasqua
(Atti 4, 8 12; 1 Gv 3, 1 – 2; Giovanni 10, 11 – 18)
In Palestina, la terra dove Gesù annunziò al mondo la Buona Novella, almeno fino agli anni Duemila si potevano incontrare ancora molti pastori con i loro greggi, che conducevano una vita non troppo diversa da quella vissuta dai pastori del tempo di Gesù. Si vedevano ampie tende nere con i pastori accampati, che conducevano le bestie al pascolo. Si spostavano in continuazione, secondo le esigenze stagionali del gregge, e sono chiamati tutt’ora “beduini”. Nei primi anni del XXI secolo, tra la Palestina e il Sinai erano circa 38.000. Essi conducono una vita dura e priva dei conforti della società moderna, ma nello stesso tempo conservano una semplicità di costumi di accattivante simpatia.
Al tempo di Gesù, la pastorizia era certamente più diffusa di oggi, tuttavia anche allora la classe dei pastori era considerata tra le più misere e disprezzate della società. Tutt’ora, in Palestina, non sono molti i pastori che possono dire di essere i proprietari del gregge. Molti di essi svolgono questo lavoro a stipendio fisso, per conto del padrone del gregge, quindi c’è una sostanziale differenza tra i pastori salariati e il datore di lavoro. Il più grave pericolo per un gregge del tempo di Gesù – e in parte è così anche oggi – era l’assalto a sorpresa dei lupi. In tale circostanza, il buon pastore affrontava il pericolo con ogni mezzo – armi, cani pastore, ecc. Il pastore salariato, invece, in caso di pericolo, abbandonava il gregge e fuggiva, unicamente preoccupato di salvarsi la vita. E In certo senso questo abbandono aveva la sua logica, in quanto il gregge non era di proprietà del pastore salariato: per lui sarebbe troppo oneroso rischiare la vita per cose che non gli appartengevano. Nel pericolo, egli non si preoccupava delle pecore. Introducendo la parabola con le parole «Io sono il buon pastore» (Gv 10,1), Gesù vuole fare intendere agli uditori che Egli non è solo un buon pastore, ma il vero, l’unico pastore del gregge messianico. Nessun’altra immagine biblica esprime così efficacemente la realtà dell’amore divino che palpita nel cuore di Gesù. Inoltre, il Maestro afferma di avere per gli uomini il diritto di attribuirsi questo titolo, perché di fatto Egli ha messo a repentaglio la sua vita per salvare le pecore, cioè i suoi figli: tutta la parabola è diretta a dimostrare questa verità. Pertanto, sia la figura del mercenario, sia la comparsa del lupo, non servono altro che a porre in risalto l’eroismo del Buon Pastore, che dà la vita per il gregge. Cristo fa qualcosa che nessun pastore, per quanto buono, sarebbe disposto a fare: «Io offro la vita per le pecore», ma a Lui è dato anche il potere di riprenderla. Al tempo di Gesù, il rapporto del pastore con il gregge non era affatto solo di tipo economico, basato sull’interesse: passando giornate intere insieme in luoghi solitari, il pastore finiva per conoscere tutto di ogni pecora. La pecora riconosce e distingue tra tutte, la voce del pastore, che spesso parla con le pecore e le chiama singolarmente per nome. E’ come una madre, che vigila sul suo bambino mentre egli gioca nel parco: lo segue con un furtivo colpo d’occhio, pronta a scattare ad ogni segnale di pericolo. Dio ha usato quest’immagine per esprimere il suo rapporto con l’umanità: «Tu pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge» (Sal 79,2).
Uno dei più bei Salmi, spesso cantati nella liturgia, esprime la tranquillità del credente di avere Dio come pastore: «Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza» (Sal 22).
Anche la morte – la valle oscura – non fa più paura, perché anche lì arriva l’occhio del Pastore. Ma la “valle oscura” non è solo la morte, è anche la prova, il buio, la crisi degli affetti, le difficoltà economiche, una seria depressione. Chi di noi non deve attraversare, prima o poi, qualcuna di queste valli oscure? Quante volte mi sono ritrovato ferito non nel corpo, ma nell’anima, non per colpa di altri, ma per colpa mia, e mi sono sentito davvero amorevolmente raccolto, curato e rimesso in piedi recitando il Rosario della Madre di Dio, che mi ha presentato risanato davanti al suo Figlio? Il Vangelo del Buon Pastore si comprende vivendolo. E’ efficace e tangibilmente salvifico.
Facendo una considerazione critica su questo Vangelo viene da chiedersi: perché Gesù usa un’immagine così tanto umana? Lui si definisce pastore e noi pecore del suo gregge. Non teme, chiamandoci pecore, di sminuire la dignità della persona umana? La pecora è un’animale che dispone di poche difese, se si smarrisce non è in grado di tornare all’ovile, per cui quando si stacca dal gregge il pastore usa bastone e frusta per governarla. La nostra dignità non si sente offesa da questa immagine? La questione di fondo è che l’uomo d’oggi rifiuta orgogliosamente di essere paragonato ad una pecora, ma di fatto lo è! Uno dei fenomeni più evidenti della nostra società è la massificazione. Stampa, televisione, internet sono detti “mezzi di comunicazione di massa” o “mass-media” soprattutto perché, oltre a informare masse di persone, le formano e le plagiano. Senza accorgersene, tanti si lasciano guidare supinamente da ogni sorta di manipolazione e di persuasione occulta. Quanti modelli di comportamento vengono seguiti per “stare al passo” di un modello pubblicitario? Il criterio da cui la maggioranza si lascia guidare nelle proprie scelte è il “così fan tutti” di mozartiana memoria. L’immagine che vedi spesso tra le folle, è quella di un gregge che si accalca. Dante ha formulato un paragone famoso, che descrive la realtà odierna: «Come le pecorelle escon del chiuso a una, a due, a tre, e l’altre stanno timidette atterrando l’occhio e ‘l muso; e ciò che fa la prima l’altre fanno…, addossandosi a lei, s’ella s’arresta, semplici e quiete, e lo ‘mperchè non sanno» (Purgatorio III, 79 – 83).
Il Buon Pastore, che è Cristo, ci propone di fare con Lui un’esperienza di liberazione che è anche la prima dimensione di ogni sacerdote, medico dell’anima. Appartenere al Suo gregge non è cadere in alcuna massificazione, ma è rendere sempre ragione di tutto quanto si fa. Ciò preserva da ogni trascinamento passivo, all’opposto delle pecore che non sanno quello che fanno, come i Romani che inchiodarono Cristo alla croce. Bisogna dare il primato alla contemplazione, cioè alla verità. Il sacerdote, il pastore delle anime della Chiesa cattolica, è colui che per te sa sempre spendere una parola che chiarisce il tuo cuore.
Il grande, salutare effetto della preghiera è quello di spalancare la nostra coscienza a tutta la realtà, quando invece il peccato restringe il nostro campo visivo fino ad osservare solo l’oggetto del desiderio. Può essere un gesto, un modo di comportarsi, di vestirsi, assunto senza vera convinzione, quando invece lo Spirito Santo porta tutta una sensibilità e un buon senso spirituale, una capacità veritativa, a cui nessun idolo del mercato può resistere. «Dove c’è lo spirito del Signore, lì c’è libertà» (2 Cor 3,17). Lì, cioè, emerge la persona capace di Dio, con la sua santa invincibile libertà. Possiamo anche essere circondati da strutture e immagini di peccato, ma per quanto limitanti esse siano, siamo spinti dalla Chiesa ad essere liberi dentro e capaci di dire di no ad ogni modello, immagine, gesto, costume, istituzione che Gesù non sceglierebbe. Poniti innanzi a Lui, chiamalo pure in causa anche davanti a piccoli acquisti e scelte quotidiane, Lui è il Buon Pastore e il Consigliere ammirabile. Ci è dato un infallibile magistero nel cuore, secondo il quale il criterio dei figli di Maria diviene “fai ciò che dispone il tuo Signore eterno, che parla al cuore”. Ciò che è bene e meglio per te ora, per gustare nella verità la realizzazione del tuo “scopo”, è la dolcissima presenza del Signore Gesù.
Domenica, 25 aprile 2021
