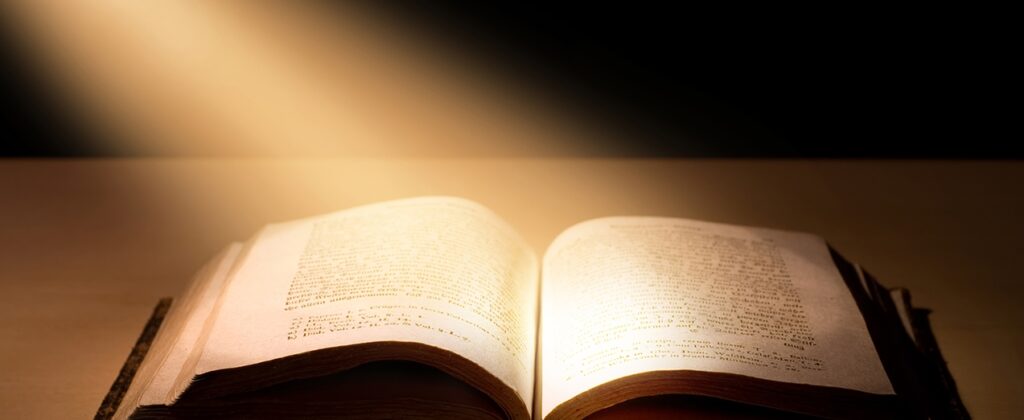
XIX° Domenica del Tempo Ordinario
(1 Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51)
«Questo è il pane che discende dal cielo»: la frase che Gesù pronuncia durante il suo discorso solenne, all’interno della sinagoga di Cafarnao, richiama un episodio dell’Antico Testamento che è narrato nella prima lettura. Il protagonista è il profeta Elia (IX sec a.C.), che dopo aver sconfitto i profeti del dio Baal (divinità fenicia) viene perseguitato dalla perfida regina Gezabele, bramosa di introdurre il culto della divinità punica in Israele. Elia fugge, ma il suo percorso diviene un pellegrinaggio alle fonti spirituali d’Israele verso il deserto del “Monte di Dio”, l’Oreb-Sinai. Il vuoto della steppa desolata si allarga anche nel cuore del profeta, che sente avanzare nella sua coscienza la disperazione: è la crisi della vocazione, che raggiunge il vertice nel panico e nel desiderio di morte. Non è però la protesta quasi suicida di Geremia e di Giobbe, è solo l’attesa sospirata di essere liberato dalla persecuzione per essere accolto da quel Dio che l’ha creato e che l’ha inviato come suo messaggero, lanciandolo in un’avventura amara e piena di sofferenze. Ma il cielo si squarcia ed ecco il pane dei nomadi, cotto su lastre di pietra roventi, deposto accanto al profeta scoraggiato: è un angelo di Dio che lo tocca e gli mostra un pane e un orcio d’acqua e gli dice: «Alzati e mangia». Egli si alza, mangia e con la forza datagli da quel pane cammina ancora per quaranta giorni e quaranta notti, fino all’Oreb. Elia è riportato dalla mano di Dio sulle strade della sua vocazione e il Sinai, il luogo natale dell’Israele di Dio, diverrà anche la sede della nuova chiamata del profeta. Non siamo anche noi, a volte, quell’Elia stanco e sfiduciato e desideroso di morire? Anche a noi viene detto perciò «alzati e mangia». Chi mangia di questo Pane, che è il Corpo del Signore, non camminerà solo per «quaranta giorni e quaranta notti», ma «vivrà in eterno». Dal tabernacolo, Cristo continua a far giungere all’uomo di ogni tempo quelle sue parole: «Venite a me voi tutti affaticati e oppressi e io vi ristorerò» (Mt 11,28).
La crisi di fede nel racconto evangelico giovanneo è, invece, espressa attraverso un’altra immagine, formulata col verbo “mormorare”, che è il verbo biblico tipico dell’incredulità di Israele nel deserto. Ora l’incredulità nasce dallo scandalo derivante dall’umanità di Cristo: come può dire di essere «disceso dal cielo» quando Gesù è noto ai compaesani come «figlio di Giuseppe»? L’Incarnazione, espressione trasparente dell’amore di Dio per l’uomo, si trasforma per loro in uno schermo opaco, che offusca gli occhi, rende dubbiosa la mente e fa mormorare le labbra. Per superare questo scandalo – replica Gesù – è necessario che il cuore si apra all’attrazione del Padre, che la coscienza ascolti la voce intima di Dio, che l’essere intero dell’uomo si lasci avvolgere dalla Grazia. Il pane comprende, nel suo simbolismo, tutta la grazia dell’esistenza del creato stesso: ne sanno qualcosa contadini, mugnai, panettieri, trasportatori e ristoratori. Un tempo, in famiglia, il giorno in cui si faceva il pane era una festa, un rito quasi religioso. L’ultimo tocco era la croce che si tracciava su ogni pagnotta e che il calore del forno dilatava e trasformava in solchi profondi e dorati. Poi si espandeva nell’aria il profumo del pane fresco, che la fame, specie durante la guerra, rendeva più desiderabile. E cos’è il pane, quando arriva sulla mensa? Il papà o la mamma che lo spezza, o lo mette semplicemente in tavola, somiglia a Gesù. Anche lui, o lei, potrebbe dire ai figli: «Prendete e mangiate: questo è il mio corpo offerto per voi». Il pane quotidiano per il genitore è davvero un po’ il suo corpo, il frutto della sua fatica e il segno del suo amore. Di quante cose, dunque, è segno il pane: di lavoro, di attesa, di nutrimento, di gioia domestica, di unità e solidarietà tra quelli che lo mangiano. Il pane è l’unico, tra tutti i cibi, che non dà mai la nausea; lo si mangia tutti i giorni e ogni volta il suo sapore cresce, ci riesce gradevole. Si sposa con tutti i cibi. Le persone che soffrono la fame non invidiano ai ricchi il caviale, o il salmone affumicato, invidiano soprattutto il pane fresco.
Durante la Consacrazione avviene la transustanziazione, cioè al momento della consacrazione il pane cessa di essere pane e diventa il corpo di Cristo: la sostanza del pane – cioè la sua realtà profonda, che si percepisce non con gli occhi, ma con la mente – cede il posto alla sostanza di Dio, o meglio alla Persona divina che è il Cristo risorto e vivo, anche se le apparenze esterne (in linguaggio teologico, gli “accidenti”) restano quelle del pane. Una donna che entra dal parrucchiere esce con una nuova acconciatura ed è trasformata, cioè cambia la forma estetica, ma sostanzialmente è sempre lei. Diciamo in tal caso: «che trasformazione», non «che transustanziazione»! Nell’Eucarestia accade il contrario: cambia la sostanza, ma non le apparenze.
San Paolo VI spiegava così: «Questo simbolo sacro della vita umana che è il pane volle scegliere Cristo per farne simbolo, ancor più sacro di sé. Lo ha transustanziato, ma non gli ha tolto il suo potere espressivo; anzi ha elevato questo potere espressivo a un significato nuovo, a un significato superiore, mistico, religioso e divino. Ne ha fatto una scala per un’ascensione che supera il livello naturale. A chi vive quest’esperienza, che è quella della fede, si apre un orizzonte straordinario: “chi crede ha la vita eterna”. Il pane disceso dal cielo e portato dall’angelo aveva sottratto solo temporaneamente Elia dalla morte. Il pane vivo disceso dal cielo “offerto ora dal Cristo fa si che “se uno lo mangia, vivrà in eterno”. Il significato di questa dichiarazione così radicale e sorprendente è da scoprire proprio all’interno della locuzione “vita eterna”».
Nel Vangelo di Giovanni essa non indica tanto la pura e semplice sopravvivenza oltre la morte, quell’immortalità dell’anima tanto celebrata nella filosofia greca, soprattutto attraverso le pagine altissime di Platone. Nel quarto Vangelo “vita eterna” è sinonimo di “vita divina”: attraverso il Pane di vita offerto dal Cristo il credente entra nella stessa vita di Dio, partecipa del suo essere, Dio si comunica a lui, lo invade, lo pervade, lo trasforma. Pensiamo alla celebre frase paolina: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20). E’ l’esperienza esaltante della grazia e dell’amore divino effuso nei nostri cuori, è l’irruzione della pace che l’Eucarestia genera nella vita del fedele, magari tormentato ed angosciato, è l’anticipazione della perfetta intimità e della gioia piena che avremo quando varcata la soglia della vita terrena, «saremo sempre col Signore» (1Ts 4,17). Naturalmente questa dichiarazione di Gesù, pur riguardando in primo luogo la vita di grazia e l’esperienza della fede, introduce anche ad una lettura diversa della morte fisica. Essa non è l’approdo al baratro del nulla e del silenzio, ma è l’incontro con la vita senza limiti, è l’ingresso nell’area infinita di Dio. E’ un modo nuovo, quindi, per interpretare e vivere quella data che noi tutti portiamo già incisa nella carne e segnata sulle nostre fronti. Lo vorremmo proporre con le parole di fede di un poeta, padre David Maria Turoldo, nella sua lirica per la morte dei genitori: «O morte, o chiara morte, / mai i loro volti furono così giovani e belli / mia madre ancora le trecce intatte e bionde e mio padre ancora l’ampia dentatura; / mai così docili e tenere le mani / e gli occhi si sereni e lucenti come il giorno / che ti degnasti sostare nella nostra casa di poveri./ Mai tanti fiori ebbero a mensa lungo tutta la loro vita/ quanti sopra le loro bare, navi salutate da tutto il paese. / Ed io a cantare dietro, a cantare sul loro silenzio / perché tu eri divenuta e mio padre e mia madre e sorella, / o morte, o divina amica!».
Domenica, 8 agosto 2021
San Domenico di Guzman Sacerdote e fondatore dei Predicatori
